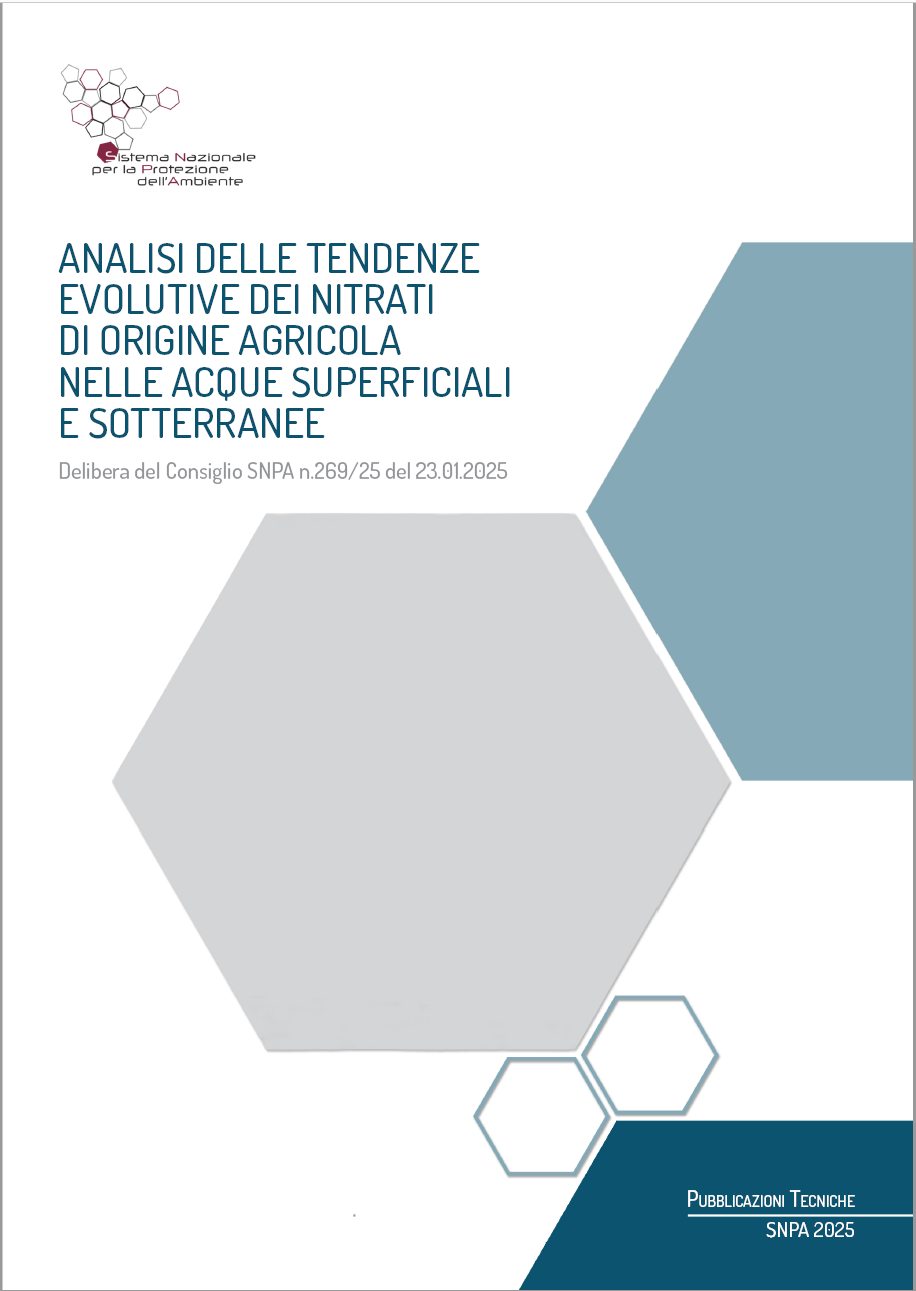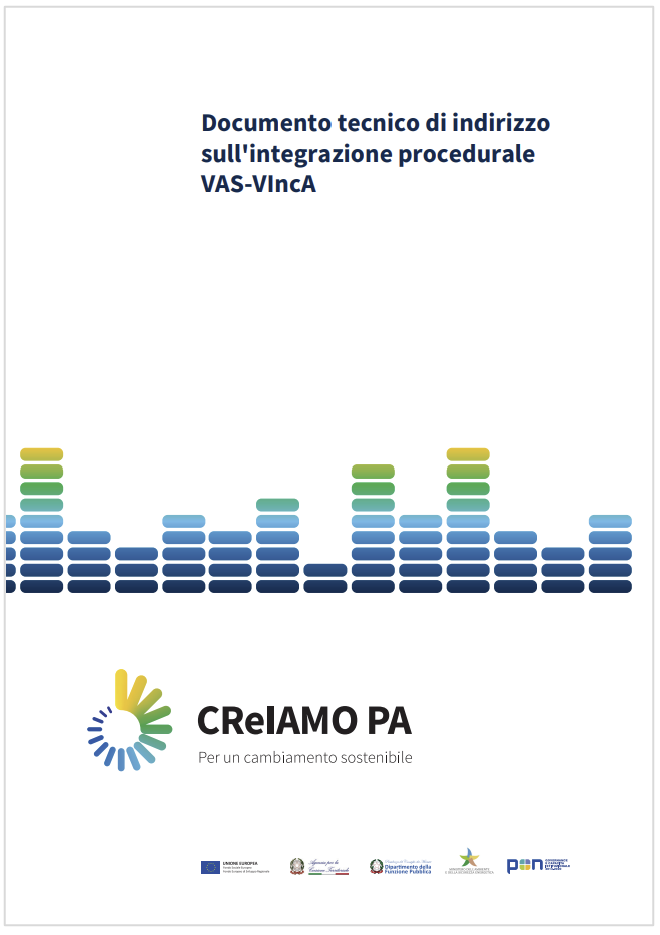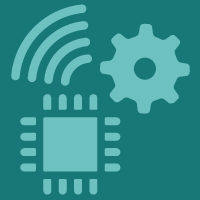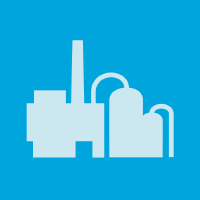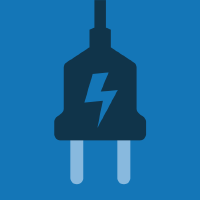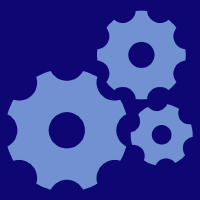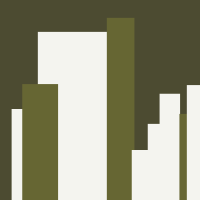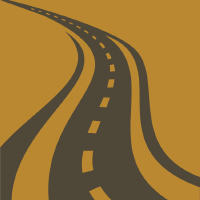Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2043
ID 24727 | 13.10.2025
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2043 della Commissione, del 10 ottobre 2025, sulla struttura, i dettagli tecnici e il processo relativi alla presentazione delle prove dell’impatto dei cambiamenti climatici e degli effetti ereditati sui suoli organici a norma del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2025/6771
GU L 2025/2043 del 13.10.2025
Entrata in vigore: 02.11.2025
___________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE, in particolare l’articolo 13 ter, paragrafo 10,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2018/841 dispone che gli Stati membri possano avvalersi della compensazione per le emissioni in eccesso e per la diminuzione degli assorbimenti in casi specifici. Conformemente al suddetto regolamento, tali emissioni e assorbimenti devono essere attribuibili all’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici con conseguenti emissioni in eccesso o diminuzione dei pozzi di assorbimento che sfuggono al controllo degli Stati membri e non sono da considerarsi disturbi naturali, oppure agli effetti ereditati da precedenti pratiche di gestione negli Stati membri con una percentuale eccezionalmente elevata di suoli organici nella loro superficie fondiaria gestita.
(2) Conformemente all’articolo 13 ter, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/841, l’aridità è una delle caratteristiche ambientali da prendere in considerazione per individuare le aree interessate dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici. È pertanto opportuno basarsi sull’indice di aridità per analizzare le variazioni del rapporto tra il fabbisogno idrico e la disponibilità di acqua nell’arco di lunghi periodi di tempo. La distribuzione geografica dei biomi e la produttività della superficie fondiaria gestita sono intrinsecamente legate all’aridità. Poiché comprende le variabili fondamentali delle precipitazioni e dell’evapotraspirazione potenziale e non risente dell’impatto locale dell’attività umana, l’indice di aridità è uno strumento affidabile per analizzare le variazioni del rapporto tra il fabbisogno idrico e la disponibilità di acqua nell’arco di lunghi periodi di tempo.
(3) Le aree che, ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, sono passate dalle classi di aridità «umida» o «subumida secca» alle classi «semi-arida», «arida» o «iper-arida» o le aree classificate come semi-aride, aride o iper-aride il cui indice di aridità è diminuito hanno problemi legati alla carenza idrica. L’aggravarsi della carenza idrica può determinare cambiamenti che si traducono in una copertura vegetale più rada e, per quanto riguarda il suolo, in un basso tenore di carbonio organico, una struttura in cattive condizioni, una ridotta biodiversità e un alto tasso di erosione. Queste evoluzioni fanno diminuire sia il potenziale di sequestro del carbonio del suolo che la sua resilienza ai cambiamenti climatici. Un’area che ha subito una simile variazione dovrebbe dunque essere considerata come interessata dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici.
(4) Per consentire l’uso di dati di qualità potenzialmente superiore che godono del sostegno della comunità scientifica, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a utilizzare indici diversi da quello di aridità per determinare le aree interessate dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici, purché dimostrino il nesso tra l’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici e la ridotta capacità di sequestro del carbonio.
(5) Nella comunità scientifica è prassi comune descrivere come eccezionale la comparsa di fenomeni naturali che raggiungono o si collocano al di sopra dell’85° percentile di una distribuzione. È pertanto opportuno considerare la percentuale di suoli organici nella superficie fondiaria gestita di uno Stato membro come eccezionalmente elevata rispetto alla media dell’Unione quando raggiunge o supera l’85o percentile della distribuzione di frequenza delle percentuali di tutti gli Stati membri.
(6) Gli effetti ereditati da precedenti pratiche di gestione dei suoli organici, come il drenaggio o l’imboschimento delle torbiere, possono accelerare il degrado dei suoli organici e, pertanto, generare emissioni dal suolo a lungo termine, rendendo gli ecosistemi meno resilienti. Le aree in cui tali pratiche di gestione precedenti hanno avuto un impatto negativo dovrebbero pertanto essere considerate come interessate dagli effetti ereditati.
(7) Al fine di non compromettere l’integrità del regolamento (UE) 2018/841 e gli sforzi degli Stati membri per conseguire gli obiettivi per il 2030 ivi stabiliti, gli Stati membri che intendono avvalersi della compensazione addizionale prevista da detto regolamento dovrebbero presentare prove delle misure adottate per migliorare le prestazioni climatiche nelle aree interessate, tanto in termini di mitigazione quanto di resilienza ai cambiamenti climatici. Tali interventi sono un prerequisito per avvalersi del meccanismo di flessibilità. Nel caso degli effetti a lungo termine dei cambiamenti climatici, gli sforzi dello Stato membro in questione dovrebbero pertanto includere pratiche e tecnologie sostenibili di gestione del suolo, mentre per quanto riguarda gli effetti ereditati da precedenti pratiche di gestione dei suoli organici gli sforzi dovrebbero includere la gestione del livello della superficie freatica o pratiche di gestione equivalenti che riducano al minimo l’impatto negativo degli effetti ereditati, tenendo conto nel contempo della resilienza delle aree interessate.
(8) Per dimostrare le emissioni in eccesso e la diminuzione degli assorbimenti è opportuno ricorrere a un confronto. Al fine di comprendere l’entità, in termini di tonnellate di CO2 equivalente, degli effetti a lungo termine dei cambiamenti climatici o degli effetti ereditati da precedenti pratiche di gestione dei suoli organici, l’area interessata dovrebbe essere confrontata con un’area non interessata che presenta le stesse caratteristiche fondamentali, quali le dimensioni, l’uso del suolo, il clima, la configurazione del terreno e il tipo di suolo.
(9) Poiché sia gli effetti a lungo termine dei cambiamenti climatici sia gli effetti ereditati da precedenti pratiche di gestione dei suoli organici richiedono un’inversione delle tendenze negative che interessano gli assorbimenti terrestri, è opportuno presentare prove delle azioni in tal senso all’inizio del periodo di conformità 2026-2030.
(10) Al fine di garantire l’allineamento con l’inventario dei gas a effetto serra presentato a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, i dati utilizzati per fornire prove dell’importo della compensazione per le emissioni in eccesso e la diminuzione degli assorbimenti dovrebbero essere conformi alle norme di trasparenza, accuratezza, coerenza, comparabilità e completezza applicate alle revisioni degli inventari dei gas a effetto serra effettuate a norma dell’articolo 38 di tale regolamento.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «indice di aridità»: il rapporto tra le precipitazioni e l’evapotraspirazione potenziale;
2) «classe di aridità»: una qualsiasi delle categorie seguenti in cui le aree sono classificate in base all’indice di aridità:
- 0,65: umida;
- 0,50-0,65: subumida secca;
- 0,20-0,50: semi-arida;
- 0,05-0,20: arida;
- < 0,05: iper-arida.
3) «suolo organico»: un suolo che soddisfa la definizione basata su norme nazionali approvate, utilizzata per la comunicazione nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) o, in mancanza di tali norme, che soddisfa i criteri elencati nelle linee guida del 2006 del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) (allegato 3 A.5. Default climate and soil classifications, capitolo 3 del volume 4).
Articolo 2 Prove riguardanti le aree interessate dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici
1. Gli Stati membri individuano le aree interessate dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici e forniscono dati geolocalizzati in merito.
2. Le prove che consentono di individuare le aree interessate dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici di cui al paragrafo 1 devono essere basate sull’indice di aridità. Un’area passata dalla classe di aridità «umida» o «subumida secca» alla classe «semi-arida», «arida» o «iper-arida» o un’area classificata come semi-arida, arida o iper-arida il cui indice di aridità è diminuito è considerata un’area interessata dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici.
3. Ove debitamente giustificato, gli Stati membri possono basare le prove dell’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici su indici diversi da quello di aridità. Questi altri indici devono dimostrare il nesso tra l’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici e la ridotta capacità di sequestro del carbonio nell’area interessata.
4. I dati utilizzati per dimostrare l’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici devono provenire da servizi meteorologici ufficiali, autorità o organismi scientifici e devono essere disponibili in tutta l’Unione.
5. Il risultato dell’analisi dell’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici deve dimostrare i cambiamenti rilevanti nelle classi di aridità, confrontando serie temporali di almeno 20 anni consecutivi nel periodo compreso almeno tra il 2001 e la fine del 2025.
6. Le prove di cui ai paragrafi da 2 a 5 devono essere verificabili e comprendere gli elementi seguenti:
a) il metodo utilizzato, i dati di ingresso utilizzati e il risultato dell’individuazione di cui al paragrafo 1;
b) una descrizione delle azioni volte a invertire la tendenza delle emissioni in eccesso o della diminuzione dei pozzi di assorbimento generate nelle aree individuate a norma del paragrafo 1.
Articolo 3 Prove riguardanti gli effetti ereditati nei suoli organici negli Stati membri con una percentuale eccezionalmente elevata di suoli organici
1. La soglia a partire dalla quale è determinata la percentuale eccezionalmente elevata di suoli organici rispetto alla media dell’Unione deve essere l’85° percentile della distribuzione di frequenza delle percentuali di suoli organici rispetto alla superficie fondiaria gestita totale in ciascuno Stato membro. I dati che determinano la percentuale di suoli organici nella superficie fondiaria gestita sono riportati nell’allegato.
2. Gli Stati membri con una percentuale eccezionalmente elevata di suoli organici determinati a norma del paragrafo 1 individuano le aree interessate dagli effetti ereditati da pratiche di gestione precedenti il 2013 e forniscono dati geolocalizzati in merito.
3. Le prove a sostegno dell’individuazione delle aree di cui al paragrafo 2 devono essere verificabili e comprendere gli elementi seguenti:
a) il metodo utilizzato, i dati di ingresso utilizzati e il risultato dell’individuazione di cui al paragrafo 2;
b) una descrizione delle precedenti pratiche di gestione di cui al paragrafo 2, compreso il periodo in cui sono state applicate, corredata di prove che dimostrino che si sono verificate;
c) una descrizione delle azioni volte a invertire la tendenza delle emissioni in eccesso generate nelle aree individuate a norma del paragrafo 2.
Articolo 4 Prove delle emissioni in eccesso e della diminuzione degli assorbimenti
1. Le prove delle emissioni in eccesso e della diminuzione degli assorbimenti fornite dagli Stati membri devono essere verificabili.
2. Per le aree individuate a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, le prove di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere basate sulla differenza tra le emissioni e gli assorbimenti totali generati nel periodo 2026-2030 in tali aree, confrontati con le emissioni e gli assorbimenti totali generati nello stesso periodo in un’area dello Stato membro che è simile in termini di clima, tipo di suolo e categorie di rendicontazione, che è stata sottoposta alle stesse pratiche di gestione e non è stata individuata a norma dell’articolo 2, paragrafo 1. Tale confronto può essere effettuato anche considerando la stessa area, soggetta alle stesse pratiche di gestione, in un periodo storico successivo al 1990 durante il quale tale area non sarebbe considerata un’area interessata dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici a norma dell’articolo 2, paragrafo 1.
3. Per le aree individuate a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, le prove di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere basate sulla differenza tra le emissioni e gli assorbimenti totali generati nel periodo 2026-2030 in tali aree, confrontati con le emissioni e gli assorbimenti totali generati nello stesso periodo in un’area dello Stato membro che è simile in termini di clima, tipo di suolo e categorie di rendicontazione e non è considerata interessata a norma dell’articolo 3, paragrafo 2.
Articolo 5 Processo per la presentazione delle prove
1. Gli Stati membri che intendono avvalersi della compensazione per le emissioni in eccesso o la diminuzione degli assorbimenti ne fanno richiesta alla Commissione entro il 30 novembre 2026. La richiesta deve includere le prove di cui all’articolo 2 o 3, a seconda dei casi.
2. La Commissione informa gli Stati membri interessati dell’esito della verifica della richiesta entro tre mesi dal ricevimento di una richiesta completa.
3. In seguito all’esito della verifica di cui al paragrafo 2, ed entro il 15 gennaio 2032, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione le prove di cui all’articolo 4, compresa una descrizione dei metodi utilizzati.
4. Entro il 31 maggio 2027, e successivamente ogni anno, lo Stato membro interessato aggiorna le prove di cui all’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), o all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), a seconda dei casi, anche in merito ai progressi compiuti verso il miglioramento della capacità di sequestro del carbonio e della resilienza ai cambiamenti climatici.
5. Le prove di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere trasparenti, accurate, coerenti, comparabili e complete.
Articolo 6 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
ALLEGATO
Percentile della percentuale di suoli organici nella superficie fondiaria gestita degli Stati membri di cui all’articolo 3, paragrafo 1
[...]
Collegati
Allegati
|
Descrizione |
Lingua |
Dimensioni |
Downloads |
 |
|
IT |
516 kB |
84 |